ORGANO
STATICO:
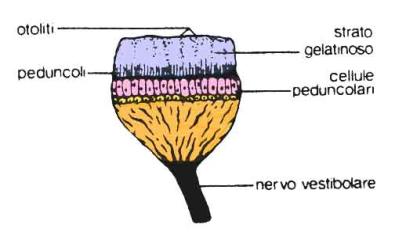
A differenza dei canali circolari, che
provvedono a fornire le sensazioni di moto, l’organo statico fornisce
le sensazioni di accelerazione. E’ costituito da minuscoli depositi di
carbonato di calcio, chiamati otoliti, che sono immersi in una sostanza
gelatinosa, entro la quale ci sono anche delle cellule peduncolari
collegate al sistema nervoso.
 Quando
la testa viene spinta in avanti, indietro o lateralmente, gli otoliti
(che seppur piccoli possiedono una loro inerzia), spostano la sostanza
gelatinosa che trasmette il movimento ai peduncoli.
Quando
la testa viene spinta in avanti, indietro o lateralmente, gli otoliti
(che seppur piccoli possiedono una loro inerzia), spostano la sostanza
gelatinosa che trasmette il movimento ai peduncoli.
Alcuni incidenti indotti dalle sensazioni
illusorie provocate dall’organo statico avvengono durante il decollo
di notte su piste poco illuminate. Sollecitati dall’accelerazione
indotta dalla manovra di decollo, gli otoliti rotolano all’indietro,
dando al pilota la sensazione di essere in forte cabrata.
DISORIENTAMENTO
SPAZIALE:
Il disorientamento spaziale si manifesta in
presenza di uno stimolo a bassa intensità prodotto da uno o più centri
preposti all’orientamento e dalla contemporanea mancanza di stimoli
visivi. E’ una normale condizione fisiologica a stimoli e sensazioni
in conflitto tra loro.
 Volo
tra le nubi e inizio di una virata verso sinistra:
Volo
tra le nubi e inizio di una virata verso sinistra:

 Il
liquido si muove nei canali e si avverte la virata.
Il
liquido si muove nei canali e si avverte la virata.
 Una
volta che la virata è stabilizzata a un rateo costante, il fluido si
ferma e si ha quindi la sensazione di essere in volo livellato.
Una
volta che la virata è stabilizzata a un rateo costante, il fluido si
ferma e si ha quindi la sensazione di essere in volo livellato.
 Supponiamo
ora di notare l’errore e di riportare l’aereo in volo livellato.
Supponiamo
ora di notare l’errore e di riportare l’aereo in volo livellato.
 Il
fluido torna a circolare e si avverte nuovamente la sensazione del moto
verso destra.
Il
fluido torna a circolare e si avverte nuovamente la sensazione del moto
verso destra.
 Quando
però si ferma la rollata al punto di livellamento, il fluido continua
a circolare per inerzia, facendo
sorgere la sensazione di essere ancora in
virata a destra.
Quando
però si ferma la rollata al punto di livellamento, il fluido continua
a circolare per inerzia, facendo
sorgere la sensazione di essere ancora in
virata a destra.
E’ facile capire come possa presto
sopraggiungere la perdita di controllo dell’aereo
Un’altra limitazione dei canali circolari
riguardo al volo è dovuta alla soglia di eccitazione delle cellule
peduncolari, per cui un movimento intorno ad un asse dell’ aereo che
avviene dolcemente può non essere avvertito.
LE
VERTIGINI:
Per le vertigini il discorso è diverso. Esse
costituiscono il sovraccarico sensoriale di alta intensità,
potenzialmente pericoloso sia per i piloti esperti in volo strumentale,
sia per i meno esperti, tanto più che possono manifestarsi anche in
condizione di visibilità illimitata. Quando tutto il liquido contenuto
nei tre canali semicircolari viene messo in circolazione
simultaneamente, l’eccessiva stimolazione delle cilia può provocare
le vertigini.
La situazione che più di altre porta al
verificarsi di questa condizione avviene quando il pilota compie un
movimento della testa mentre l’aereo sta virando. Le conseguenze sono
drammatiche: il pilota ad ogni effetto pratico è reso inabile. Può
avere le sensazioni di nuotare, oppure può sentire l’aereo che
capitombola all’indietro o lateralmente. Sensazione che solitamente
sono accompagnate da stordimento, nausea, vomito ed il fenomeno dell’
nistagmo, ossia l’oscillazione dei muscoli oculari.
COSA
FARE ALLORA?
 La
regola di base è quella di eseguire molti allenamenti di volo
strumentale. Quando è disponibile un riferimento visivo, le sensazioni
illusorie non si manifestano, poiché lo stimolo nervoso generato dalla
vista cancella gli stimoli più deboli generati dall’organo
dell’equilibrio.
La
regola di base è quella di eseguire molti allenamenti di volo
strumentale. Quando è disponibile un riferimento visivo, le sensazioni
illusorie non si manifestano, poiché lo stimolo nervoso generato dalla
vista cancella gli stimoli più deboli generati dall’organo
dell’equilibrio.
I piloti più esperti sono così in grado di
ignorare queste sensazioni e di credere fermamente a quanto gli
strumenti stanno loro indicando.
PERCHE’
SI SOFFRONO I G?
L’organismo durante una manovra aerea risulta
soggetto a variazioni di velocità e di direzione:
 Accelerazioni
rettilinee:
Accelerazioni
rettilinee:
Generate
in seguito a variazioni di velocità che solitamente agiscono in senso
rettilineo ed hanno valori relativamente modesti.
In
decollo la forza subita dal pilota è orientata petto-schiena,
producendo una sensazione di insaccamento del corpo al seggiolino
(viceversa in atterraggio) che risulta facilmente tollerabile e non
spiacevole.
Sono
quelle accelerazioni che causano brusche variazioni della pressione
sanguigna e dell’irrorazione celebrale. Tali forze stimolano,
attraverso i recettori pressori, la produzione di adrenalina e
noradrenalina che favoriscono il ripristino dei valori normali.

 Accelerazioni centrifughe:
Accelerazioni centrifughe:
Per
capire come può variare l’entità di tale componente è necessario
analizzare il diagramma delle forza durante una virata.
L’effetto
della forza di gravità resta costante a qualsiasi velocità mentre la
componente centrifuga è inversamente proporzionale al raggio di virata,
cioè al raggio di curvatura della traiettoria descritta dal velivolo.
Essa è invece direttamente proporzionale al quadrato della velocità;
raddoppiando pertanto la velocità senza aumentare il raggio, la forza
centrifuga aumenta del quadruplo.
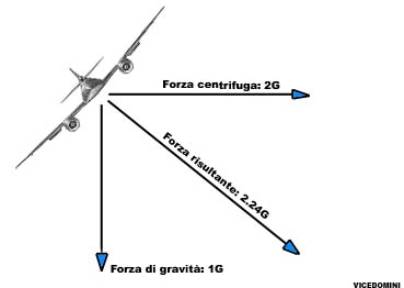
Le
ripercussioni sull’organismo sono, in mancanza di visibilità,
l’insorgenza del disorientamento spazio-temporale a causa
della stimolazione dei canali semicircolari. In tale situazione, il corpo reagisce stimolando, attraverso i recettori posizionali, il recupero
dell’ equilibrio.
 Ma…
Ma…
Durante
il volo acrobatico il manifestarsi di tutte queste alterazioni fisiche
avviene in un lasso di tempo molto breve. Di conseguenza l’organismo
si confonde ed insorgono dei malori quali nausea, capogiri, sudori freddi,
ecc..
FATTORI
COMPLEMENTARI:
 Lo
sballottamento:
Lo
sballottamento:
 Causa
la dislocazione dei visceri
Causa
la dislocazione dei visceri
 Sollecita i sistemi simpatico e parasimpatico
Sollecita i sistemi simpatico e parasimpatico
 Squilibra il sistema di regolazione termica
Squilibra il sistema di regolazione termica
 Aumenta la sudorazione dell’individuo
Aumenta la sudorazione dell’individuo
 Lo
stress:
Lo
stress:
Il
volo acrobatico è una tecnica molto emozionante e faticosa. Se a ciò
si aggiunge lo sforzo psico-fisico del pilotare un velivolo, si ha che in
condizioni di stress eccessivo, l’organismo risulta maggiormente
soggetto agli effetti collaterali esposti precedentemente, mandando in
crisi il pilota.
 L’alcol
ed il fumo:
L’alcol
ed il fumo:
Ovviamente
tali elementi non possono che accentuare gli stress dell’organismo
agli sforzi esercitati.
In
particolare agiscono sul sistema nervoso centrale riducendo la
resistenza alla fatica psico-fisica.
ALTRI
FATTORI:
Gli
altri fattori che inducono ad una variazione delle condizioni corporee
sono:
 La
Glicemia:
La
Glicemia:
Un
basso livello di zuccheri nel sangue riduce sensibilmente la resistenza
ai G, a causa dell’aumento del consumo di glucosio da parte delle
cellule celebrali
 L’età:
L’età:
La
massima resistenza agli effetti gravitazionali si ha intorno ai 30 anni.
Meno resistenti sono i giovanissimi, nei quali l’organismo non ha
ancora raggiunto il suo completo sviluppo. I soggetti più anziani
resistono maggiormente ai G poiché, con l’avanzare dell’età,
subentra un aumento medio della pressione arteriosa ed una perdita di
distensibilità delle pareti vascolari.
 Il
G-Onset:
Il
G-Onset:
Il
G-Onset, è la rapidità con la quale il fattore di carico passa da 1 al
valore finale indotto dalla manovra.
E’ dimostrato
che il G-Onset è il fattore predominante nei casi di incapacità del
pilota. Non è infatti tanto importante il numero di G massimi, ma la
rapidità con la quale vengono raggiunti.
 Elevati
valori di G-Onset (>10g/s) mettono in crisi il sistema
cardiovascolare perché:
Elevati
valori di G-Onset (>10g/s) mettono in crisi il sistema
cardiovascolare perché:
 La
variazione di pressione sanguigna è troppo rapida per
essere compensata,
La
variazione di pressione sanguigna è troppo rapida per
essere compensata,
 Il pilota non ha tempo a sufficienza per effettuare azioni
volontarie di contrasto come la contrazione addominale ecc..
Il pilota non ha tempo a sufficienza per effettuare azioni
volontarie di contrasto come la contrazione addominale ecc..
I
G POSITIVI:
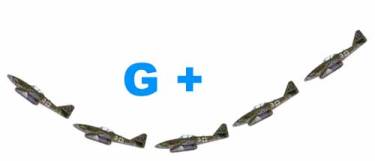
Ottenuti durante manovre quali la richiamata,
durante la quale il sangue fluisce dalla testa ai piedi.
 Effetti
fisici in manovra:
Effetti
fisici in manovra:
 +2
G: si ha principalmente sensazione di pesantezza degli arti,
+2
G: si ha principalmente sensazione di pesantezza degli arti,
 +3
G: le gambe diventano troppo pesanti da sollevare,
+3
G: le gambe diventano troppo pesanti da sollevare,
 +4
G: la testa ed anche il tronco sono mantenuti eretti con difficoltà,
+4
G: la testa ed anche il tronco sono mantenuti eretti con difficoltà,
 +5
G: non si ha più il controllo dei movimenti muscolari,
+5
G: non si ha più il controllo dei movimenti muscolari,
 +6 G: non si possono alzare le braccia al di sopra del
capo; è
ancora
+6 G: non si possono alzare le braccia al di sopra del
capo; è
ancora
possibile
eseguire piccoli movimenti delle dita e
delle mani, ma solo quando l’altro braccio è ben appoggiato.
 Effetti
visivi in manovra:
Effetti
visivi in manovra:
Tali effetti sono dovuti alla variazione di
irrorazione sanguigna degli occhi:
 +3 G: diminuisce la nitidezza ed il contrasto dei G, e
si ha
offuscamento prima della visione periferica, poi anche della
visione centrale.
+3 G: diminuisce la nitidezza ed il contrasto dei G, e
si ha
offuscamento prima della visione periferica, poi anche della
visione centrale.
 +4 G: progressivo restringimento del campo visivo e
subentra l’annebbiamento generale della vista.
+4 G: progressivo restringimento del campo visivo e
subentra l’annebbiamento generale della vista.
 +5 e +6 G: un velo nero cala davanti agli occhi e si ha
la
perdita completa di vista, cioè la visione nera (“black out”).
+5 e +6 G: un velo nero cala davanti agli occhi e si ha
la
perdita completa di vista, cioè la visione nera (“black out”).
Non comporta perdita di conoscenza e
interrompendo la manovra acrobatica, solo dopo qualche secondo dal
termine di essa, la vista riprende le sue funzioni normali ed i muscoli
riacquistano la possibilità di contrarsi senza sforzo.
RESISTERE
AI G POSITIVI:
Nel caso in cui il pilota debba affrontare una condizione di G positivi
(fisicamente più sopportabili rispetto a quelli negativi) si eseguono
le manovre M1 e L1 non
appena insorge il G-Onset.
 Manovra
M1:
Manovra
M1:
E’
una manovra simile allo sforzo di sollevamento di un peso:
 Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome
Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome
 Espirare lentamente e con forza attraverso la glottide
parzialmente chiusa
Espirare lentamente e con forza attraverso la glottide
parzialmente chiusa
 Ispirare
rapidamente
Ispirare
rapidamente
 Manovra
L1:
Manovra
L1:
Simile
alla manovra M1:
 Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome
Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome
 Trattenere il respiro mantenendo la glottide chiusa
Trattenere il respiro mantenendo la glottide chiusa
 Espirare
rapidamente, inspirare e ripetere
Espirare
rapidamente, inspirare e ripetere
 Tute anti-G:
Tute anti-G:
 Per
aumentare la tolleranza umana agli effetti dell’ aumento del fattore
di carico, vengono generalmente usate dai piloti militari di aviogetti
le cosiddette tute anti-G.
Per
aumentare la tolleranza umana agli effetti dell’ aumento del fattore
di carico, vengono generalmente usate dai piloti militari di aviogetti
le cosiddette tute anti-G.
Si tratta di speciali indumenti protettivi
costituiti da vesciche pneumatiche o da tubi rigonfiabili
automaticamente e proporzionalmente al numero di G cui il soggetto è
esposto: tale rigonfiamento, attuato principalmente in corrispondenza
dell’ addome, delle cosce e delle gambe, e ad accelerazioni positive
di 2-3 G, contrasta l’insaccamento ed il ristagno del sangue nelle
regioni inferiori del corpo, facilitando quindi l’afflusso del sangue
nelle regioni superiori e aumentando di circa 1-2 G la resistenza del
pilota.
I
G NEGATIVI:

Molto più affaticanti e faticose sono le
esposizioni alle accelerazioni dirette in senso piedi-testa, cioè ai
cosiddetti G negativi che possono verificarsi:
 Durante l’affondata dal volo orizzontale a quello di
picchiata,
Durante l’affondata dal volo orizzontale a quello di
picchiata,
 Nel looping rovescio,
Nel looping rovescio,
 Nel volo rovescio.
Nel volo rovescio.
I queste condizioni si verifica l’afflusso ed
il ristagno della massa sanguigna nella parte superiore del corpo,
specie nella zona celebrale.
 I disturbi che si
verificano sono:
I disturbi che si
verificano sono:
 Congestione del viso,
Congestione del viso,
 Difficoltà respiratorie,
Difficoltà respiratorie,
 Ronzii e fischi alle orecchie
Ronzii e fischi alle orecchie
 Cefalea persistente,
Cefalea persistente,
 Visione rossa dovuta all’eccessiva irrorazione degli
occhi
Visione rossa dovuta all’eccessiva irrorazione degli
occhi
RESISTERE
AI G NEGATIVI:
Non
esistono manovre di efficacia pari a quelle delle manovre M1 e L1,
d’altro canto è impensabile agire con le tute anti-G negli organi
superiori, per ovvi motivi.
 All’insorgere
del G negativo:
All’insorgere
del G negativo:
 Inspirare lentamente dilatando il torace e l’addome
Inspirare lentamente dilatando il torace e l’addome
 Cercare di completare l’ispirazione quando il G cessa
Cercare di completare l’ispirazione quando il G cessa
Sul piano pratico le accelerazioni negative
vengono evitate con manovre opportune: ad esempio eseguire la picchiata
inclinando il velivolo fortemente sul lato ed esecuzione di una virata
in discesa.
I G negativi vengono di norma evitati poiché,
anche da un punto di vista strutturale, i velivoli di norma resistono
fino ai –2 G prima di subire danni strutturali.
ALIMENTAZIONE
CORRETTA ED ATTIVITA’ CONTROLLATE:
 In
allenamento o preparazione aerobica:
In
allenamento o preparazione aerobica:
 Rispettare il ciclo del sonno
Rispettare il ciclo del sonno
 Non
volare stanchi o stressati
Non
volare stanchi o stressati
 Evitare di assumere alcol
Evitare di assumere alcol
 Prestare attenzione ai farmaci
Prestare attenzione ai farmaci
 Anticoagulanti (anche aspirina)
Anticoagulanti (anche aspirina)
 Analgesici o tranquillanti
Analgesici o tranquillanti
 Alimentazione:
Alimentazione:
Volare
a stomaco vuoto o a stomaco pieno?
A
tale domanda non esiste una risposta univoca, dipende da fattori
personali dove ciascuno deve capire da solo come si trova meglio. In
linea di massima, tuttavia, è meglio evitare di mangiare molto per ovvi
motivi.
 Prediligere:
Prediligere:
 Carboidrati quali pasta e pane
Carboidrati quali pasta e pane
 Carni
bianche o a basso contenuto di grassi (pollo, tacchino)
Carni
bianche o a basso contenuto di grassi (pollo, tacchino)
 Frutta e verdura
Frutta e verdura
 Acqua e bevande non gassate (poiché la disidratazione
sopravviene soprattutto in condizioni di
stress)
Acqua e bevande non gassate (poiché la disidratazione
sopravviene soprattutto in condizioni di
stress)
 Zuccheri (da mantenere sempre elevati nell’organismo)
Zuccheri (da mantenere sempre elevati nell’organismo)
PREPARAZIONE
ATLETICA:
Non
esistono dati convincenti sull’utilità del training aerobico per
aumentare la resistenza ai G.
E’
invece dimostrato che un eccessivo allenamento aerobico predispone alla
perdita di conoscenza in volo. A tale attività viene preferito
l’allenamento isometrico (pesi stretching) che favorisce un aumento
significativo ( anche 1.5 – 2 G) della resistenza ai G. In linea
generale una buona forma fisica è necessaria ad ottenere un
soddisfacente livello di tolleranza al volo acrobatico.

